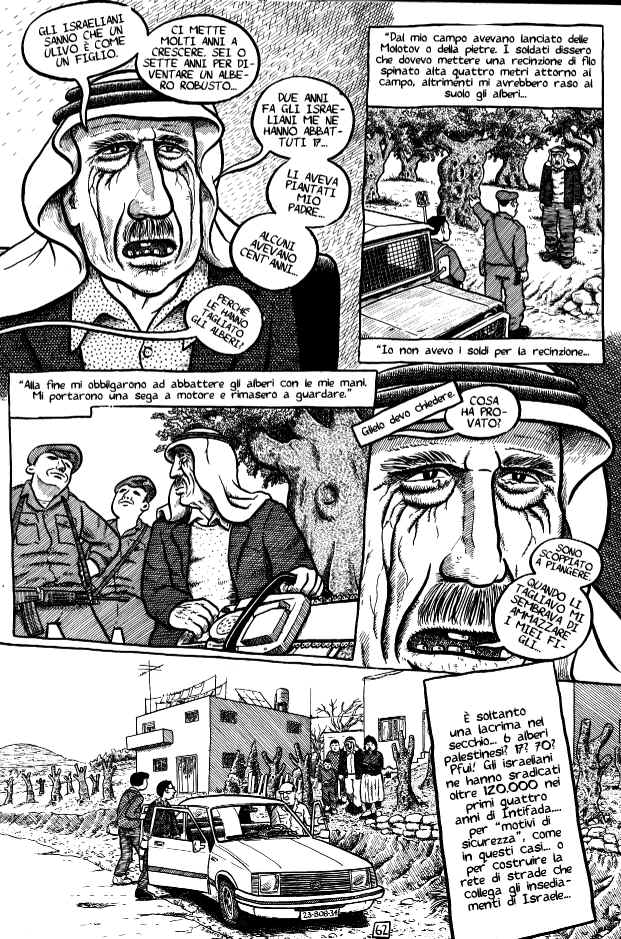A un certo punto passai dalle pagine di Topolino, Geppo e Braccio di Ferro (i miei fumetti preferiti quand'ero bambino, e non necessariamente in quest'ordine) a quelle di Tex.
Le guardavo soltanto: ero troppo piccolo per leggere le storie. Ma quei grandi spazi, quelle cavalcate solitarie, quei canyon scavati nella roccia, e soprattutto quei suoni - bang! - mi lasciavano senza fiato: fantasticavo per ore su quei panorami, su quei volti duri, sulle sparatorie.
Il bianco e nero non era un problema. Il colore ce lo mettevo io. Con la fantasia, quasi sempre. Ma qualche volta anche con i pennarelli carioca.
Però quelle storie dovevano essere in bianco e nero: era un mondo adulto e quelli erano i suoi colori.
Tex era in casa perché lo leggeva mio padre, ritrovando sulla carta la passione per il western che immagino lo avesse nutrito da ragazzo: mi sembrava che in quelle storie scorresse una corrente silenziosa di complicità tra me e lui.
E così non credo che si possa salutare Sergio Bonelli senza parlare dal modo in cui le sue storie hanno formato il mio (ma anche il nostro) immaginario.
Le storie di Tex che leggevo da bambino, in realtà, erano probabilmente del padre di Sergio, Gian Luigi, che aveva inventato il personaggio e lo scriveva dal 1948.

Fra parentesi: che emozione quando da un rigattiere trovai per caso il primo numero di Tex in formato striscia. Lo comprai subito. Chissà dov'è, ora.
Le storie di Tex che leggevo da bambino, in realtà, erano probabilmente del padre di Sergio, Gian Luigi, che aveva inventato il personaggio e lo scriveva dal 1948.

Fra parentesi: che emozione quando da un rigattiere trovai per caso il primo numero di Tex in formato striscia. Lo comprai subito. Chissà dov'è, ora.
Erano storie che guardavo con rispetto e ammirazione, ma - come dire - un po' da lontano. Non riuscivano a coinvolgermi: evidentemente non stuzzicavano il mio immaginario.
Poi un giorno scoprii Zagor in cui ritrovai l'avventura, l'esotico, quel grido che mi ricordava tanto Tarzan, un costume sgargiante, molto poco adatto alla vita nella giungla, ma così forte ai miei occhi di ragazzino. E poi, volete mettere il fascino di una casa nella palude? E gli scienziati pazzi? gli extraterresti? i vampiri, addirittura?
Zagor era scritto da Guido Nolitta, pseudonimo di Sergio Bonelli, ed era completamente diverso da Tex. Così come lo era Mister No, un altro personaggio "di confine", al limite fra generi diversi ma, soprattutto, con un carattere complesso, spesso preda di dubbi, di rimorsi: quasi un antieroe. Non era il "mio" eroe, ma rappresenta bene la cifra narrativa di Sergio Bonelli e la capacità di una casa editrice tradizionale di evolvere, pur restando fedele a se stessa.
E poi, quando avevo 13 e 17 anni, sono venuti altri personaggi, Martin Mystère e Dylan Dog, che intercettavano lo spirito del tempo e che, in misura diversa, sono stati "miei". Sarebbe troppo lungo, ora, raccontarli, descrivere come evolvevano seguendo o anticipando la cultura popolare di quegli anni. Ma per me, allora, quegli albi erano Sergio Bonelli.
Di lui, da allora in avanti, mi è capitato di leggere solo i messaggi che ogni tanto scriveva per i suoi lettori, presentando le novità della casa editrice, tessendo i fili di un rapporto che non si indeboliva col tempo, ma anzi continuava ad evolvere.
Sergio Bonelli e la sua casa editrice rappresentano bene quell'artigianalità industriale (o quell'industria artigianale) che è caratteristica della cultura popolare italiana: una forza nel nostro asfittico panorama che, nonostante alcuni limiti, continua a proporre novità, cercando formule editoriali nuove per combattere una crisi che è sempre strisciante.Ora, immagino, sarà il turno di una nuova generazione.
Ma spero che la strada dell'avventura sia ancora lunga. E sono convinto che Sergio abbia solo accelerato il passo per vedere che cosa c'è un po' più avanti.