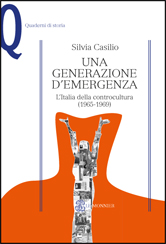La cultura in Abruzzo non se la passa bene.
Giusto per dare qualche cifra indicativa, nel 2011 la graduatoria di quelli che si è soliti chiamare "consumi culturali" era questa:
su 1.266.000 abitanti (oltre i sei anni), il 58,8% è andata al cinema, il 33,8% ha assistito ad uno spettacolo sportivo, il 24,2% è andata a sentire un concerto (ma solo l'8,1% un concerto di musica classica); il 23,7% è andata in un museo e il 23,2% ha frequentato discoteche, balere o simili, il 19,7% è andato a teatro e il 17% ha visitato un sito archeologico o un monumento (si tratta di dati istat e se vi interessa il dettaglio, andate qui).
Lo scandalo che ha visto protagonista l'assessore regionale alla cultura e che, per i suoi toni boccacceschi (o forse da commedia pecoreccia dei tardi anni Settanta, non saprei), ha ottenuto una certa visibilità nelle cronache nazionali (volete un promemoria? ecco qui), non ha fatto che aggravare le cose.
O forse, semplicemente, rivelarle.
Fatto sta che, nell'imminenza delle elezioni regionali, sono molti i soggetti privati e pubblici che si stanno muovendo per richiamare l'attenzione sul ruolo centrale che la cultura può e deve svolgere nell'agenda politica regionale. Lo sta facendo il Club Unesco Città di Pescara che, attraverso il lavoro di un focus group, vuole individuare i punti centrali di un piano straordinario per la cultura in Abruzzo (trovate qui il comunicato stampa). Lo ha fatto l'Università di Teramo che, insieme alla Provincia, ha organizzato l'11 aprile scorso un incontro intitolato #tesorocultura: qui, qui, qui e qui trovate una breve rassegna stampa dell'evento, in cui si accenna anche al video che ho realizzato insieme ad alcuni studenti della facoltà di Scienze della comunicazione su questo tema.
Abbiamo scelto di intitolarlo Con le ali legate. Impressioni sulla cultura in Abruzzo e potete vederlo qui sotto (ma visualizzatelo direttamente su youtube, per vederlo meglio, che qui è un po' costretto).
Non è un reportage sullo stato della cultura in Abruzzo (che pure avrebbe meritato di essere fatto), né un viaggio sulle possibilità inespresse di una regione (cosa che certo non sarebbe di scarso interesse) ma solo una - come dire? - "fotografia emotiva" di quello che c'è qui ed ora, e dello stato d'animo di chi, per professione e per passione, guarda alla realtà della regione e di coloro che provano a fare cultura.
E' uno sguardo limitato, ristretto, come ristretto è il numero degli interlocutori.
Che tuttavia, per quanto pochi, sono stati pur sempre troppi per il minutaggio che ci eravamo dati come obiettivo iniziale.
Ci eravamo detti, progettando il lavoro: dieci minuti massimo; e pensavamo a sette.
Siamo arrivati a diciotto: e ce ne sarebbero voluti venti, o forse più.
Il fatto è che ci sarebbe tanto da dire. Tante riflessioni da fare e tante storie da raccontare. Storie di passione e di sacrificio, spesso. E fin troppo spesso, di sprechi e di dissipazioni (di risorse, bellezza, dedizione, amore). Ma anche storie di successi e di inesausta volontà. Tutte storie che aspettavano solo qualcuno che le volesse ascoltare.
Se questo video sarà anche solo un piccolo tassello di un percorso (lungo e faticoso) di risalita - e di rinascita, diciamolo pure - avrà fatto molto di più di quanto chi lo ha realizzato potesse sperare nel momento in cui lo stava facendo.
Noi abbiamo lavorato di corsa, come sempre accade in questi casi.
Ma ve lo posso dire con sincerità: è stato bello progettare e discutere con alcuni studenti di un tema del genere, così complesso e scivoloso; ragionare con loro sulle domande da fare; immaginare lo stile da adottare.
E' stato bello anche pensare soluzioni visive che poi non si sono potute adottare.
Scegliere.
Scartare.
E' stato un bel modo di fare università: certo diverso da una lezione; meno complesso - forse - di una dissertazione teorica. Ma un modo per crescere ed imparare, questo sì: di sicuro. Per loro e per me. E anche questa è cultura e trasmissione di sapere.
Una generazione d'emergenza ad Ascoli Piceno
Ecco qua:
Se volete qualche anticipazione in forma di recensione potete andare qui. E altre ne troverete, se vi farete un giro su internet.
Poi ne riparliamo venerdì.
Per ora vi dico solo che una delle cose che mi hanno colpito del libro non è nel libro, ma sul sito della casa editrice che sta facendo un lavoro secondo me utile: mettere a disposizione dei lettori dei materiali aggiuntivi, di vario genere (documentario, iconografico), che non sono potuti confluire nel volume. Per vederli seguite il link.
Si tratta di una sorta di compendio al già ricco materiale presente nel libro, utile per approfondire alcuni aspetti, ma anche per cogliere i processi di selezione che ha fatto l'autrice: selezione che, di fronte ad un materiale eterogeneo come quello di cui si è servita, è già parte del processo di analisi e di scrittura.
Potrebbe essere fatto meglio?
Potrebbe essere fatto meglio.
Non tanto dal punto di vista della selezione, nel cui merito non entro perché il libro non l'ho scritto io, ovviamente, ma da quello dell'organizzazione per il web. L'uso di pdf mi sembra una scorciatoia (di cui capisco le motivazioni, economiche e di funzionalità innanzitutto) che finisce per sminuire la forza dei materiali. Meglio sarebbe stato, secondo me, osare dei percorsi multimediali da consultare on line: si sarebbe, forse, rischiato di fare perdere il lettore fra tutti questi rimandi, ma certo lo si sarebbe portato anche a cogliere - almeno in parte - la complessità e l'eterogeneità di quella cultura a cui Silvia Casilio ha cercato di dare sistematicità.
Comunque una strada interessante che, percorsa in modo sistematico e con un minimo di investimenti, potrebbe rendere molto più permeabile il confine fra libri cartacei e digitali, soprattutto in ambito accademico (ma anche divulgativo).
Etichette:
cose da leggere,
dove vado e cosa faccio,
libri
Tra luoghi e mestieri, il giorno dopo (quasi una recensione)
Come vi avevo annunciato, ieri sono stato alla Casa della Memoria e della Storia di Roma per presentare Tra luoghi e mestieri, il libro pubblicato dalle edizioni Ca' Foscari e curato da Gilda Zazzara.
E' stata una bella occasione per discutere di lavoro, precarietà, identità, ma non è stata certo una presentazione - come dire? - ordinaria.
"Ragazzi, è stata una bella cosa. Non so esattamente cosa, ma è stata bella", ci hanno detto dal pubblico alla fine.
 In effetti, assenze e presenze impreviste hanno finito per stravolgere il classico modulo della presentazione dei libri:
In effetti, assenze e presenze impreviste hanno finito per stravolgere il classico modulo della presentazione dei libri:
il moderatore introduce
parla il primo relatore
parla il secondo
"ci sono interventi dal pubblico?"
silenzio
"allora grazie a tutti".
E alla fine abbiamo fatto pure un piccolo aperitivo con il pubblico, in cui la discussione è continuata a piccoli gruppi, mischiandosi con le chiacchiere sull'attualità politica.
Naturalmente, non ho potuto usare il testo che avevo preparato. E allora lo metto qui sotto, quasi come se fosse una recensione.
Chi fosse interessato, può continuare dopo il salto.
Chi invece vuole leggersi il libro può seguire il link, perché la casa editrice lo ha pubblicato in forma digitale e gratuita.
E' stata una bella occasione per discutere di lavoro, precarietà, identità, ma non è stata certo una presentazione - come dire? - ordinaria.
"Ragazzi, è stata una bella cosa. Non so esattamente cosa, ma è stata bella", ci hanno detto dal pubblico alla fine.
 In effetti, assenze e presenze impreviste hanno finito per stravolgere il classico modulo della presentazione dei libri:
In effetti, assenze e presenze impreviste hanno finito per stravolgere il classico modulo della presentazione dei libri:il moderatore introduce
parla il primo relatore
parla il secondo
"ci sono interventi dal pubblico?"
silenzio
"allora grazie a tutti".
E alla fine abbiamo fatto pure un piccolo aperitivo con il pubblico, in cui la discussione è continuata a piccoli gruppi, mischiandosi con le chiacchiere sull'attualità politica.
Naturalmente, non ho potuto usare il testo che avevo preparato. E allora lo metto qui sotto, quasi come se fosse una recensione.
Chi fosse interessato, può continuare dopo il salto.
Chi invece vuole leggersi il libro può seguire il link, perché la casa editrice lo ha pubblicato in forma digitale e gratuita.
Etichette:
libri,
recensioni
Tra luoghi e mestieri: lunedì 24 febbraio
Lunedì 24 febbraio sarò alla Casa della memoria e della storia di Roma (Via S. Francesco di Sales, 5) per presentare questo libro.
Cominciamo alle 16, e avrò il piacere di parlarne con tre delle autrici (Gilda Zazzara, Eloisa Betti e Stefania Ficacci) e con Giovanni Contini.
Si tratta di un volume a più mani (gli altri autori sono Stefano Gallo, Maria Porzio e Eloisa Betti) che raccoglie alcuni saggi sul lavoro scritti da ricercatori giovani dal punto di vista anagrafico ma maturi per le capacità di ricerca e analisi.
Naturalmente, qui non vi anticipo niente di quello che dirò: se siete interessati - e siete a Roma - venite anche voi alla discussione.
Però voglio segnalarvi qualche elemento in più per inquadrare il libro (e magari farvi venire un po' di curiosità).
I saggi affrontano alcuni temi del lavoro: e già questo è un punto a loro favore, in epoca di deindustrializzazione, esternalizzazioni e lavoro che, dopo essersi fatto immateriale, sembra farsi sempre più evaniescente. Ma lo fanno raccontando lavori tanto inusuali (non perché poco frequenti ma perché poco indagati) quanto interessanti: i mille mestieri dei quartieri popolari di Roma, i lavoratori del mare di Torre del Greco, le rammendatrici vicentine e così via. E lo fanno soprattutto attraverso gli strumenti della storia orale, da una prospettiva che non si può più definire insolita ma che, più la si usa più continua a rivelarsi ricca dal punto di vista euristico.
Del resto, le ricerche nascono all'interno di un seminario dell'Università Ca' Foscari di Venezia chiamato "Ascoltare il lavoro" (qui il programma dell'edizione 2013), un'iniziativa che ormai ha qualche anno e che mi auguro continuerà a lungo. Anche perché ascoltando questi lavori del passato (il cuore dei racconti si situa tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta) continuiamo a porci domande sui lavori di oggi, ma anche sul modo in cui il lavoro e i suoi mondi sono stati raccontati fin'ora, all'ombra di idee e categorie la cui compattezza sembra venire sempre più erosa dalle ricerche di oggi.
Ci vediamo lì, allora. (questa è la locandina: se ci cliccate sopra si ingrandisce)
Oppure - forse - ci rileggiamo da queste parti, così vi dico com'è andata e vi racconto qualcosa di più sul libro.
Cominciamo alle 16, e avrò il piacere di parlarne con tre delle autrici (Gilda Zazzara, Eloisa Betti e Stefania Ficacci) e con Giovanni Contini.
Si tratta di un volume a più mani (gli altri autori sono Stefano Gallo, Maria Porzio e Eloisa Betti) che raccoglie alcuni saggi sul lavoro scritti da ricercatori giovani dal punto di vista anagrafico ma maturi per le capacità di ricerca e analisi.
Naturalmente, qui non vi anticipo niente di quello che dirò: se siete interessati - e siete a Roma - venite anche voi alla discussione.
Però voglio segnalarvi qualche elemento in più per inquadrare il libro (e magari farvi venire un po' di curiosità).
I saggi affrontano alcuni temi del lavoro: e già questo è un punto a loro favore, in epoca di deindustrializzazione, esternalizzazioni e lavoro che, dopo essersi fatto immateriale, sembra farsi sempre più evaniescente. Ma lo fanno raccontando lavori tanto inusuali (non perché poco frequenti ma perché poco indagati) quanto interessanti: i mille mestieri dei quartieri popolari di Roma, i lavoratori del mare di Torre del Greco, le rammendatrici vicentine e così via. E lo fanno soprattutto attraverso gli strumenti della storia orale, da una prospettiva che non si può più definire insolita ma che, più la si usa più continua a rivelarsi ricca dal punto di vista euristico.
Del resto, le ricerche nascono all'interno di un seminario dell'Università Ca' Foscari di Venezia chiamato "Ascoltare il lavoro" (qui il programma dell'edizione 2013), un'iniziativa che ormai ha qualche anno e che mi auguro continuerà a lungo. Anche perché ascoltando questi lavori del passato (il cuore dei racconti si situa tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta) continuiamo a porci domande sui lavori di oggi, ma anche sul modo in cui il lavoro e i suoi mondi sono stati raccontati fin'ora, all'ombra di idee e categorie la cui compattezza sembra venire sempre più erosa dalle ricerche di oggi.
Ci vediamo lì, allora. (questa è la locandina: se ci cliccate sopra si ingrandisce)
Oppure - forse - ci rileggiamo da queste parti, così vi dico com'è andata e vi racconto qualcosa di più sul libro.
Etichette:
cose da leggere,
tourné
Il ricordo non si esaurisce in un giorno
27 gennaio, giorno della memoria.
Molti scrivono oggi sulla Shoah. Leggendo qua e là può venire il dubbio che la memoria che oggi ci si ricorda di praticare non sia un vero atto di rammemoriazione, ma solo una forma di partecipazione - più o meno formale - ad un rito civile.
E' utile? La domanda risuona sin da quando, 14 anni fa, questo giorno fu introdotto per legge nel nostro calendario civile. Quanto accaduto l'altro giorno a Roma (i pacchi con le teste di maiale recapitati alla Sinagoga di Roma, al museo che ospita una mostra sulla Shoah e all'ambasciata israeliana: qui e qui la cronaca, qui un commento di Gad Lerner) dimostra che sì, è utile. Ancora e sempre.
Io, oggi, non aggiungerò le mie parole a quelle di chi, con maggiore competenza di me, parla di Shoah e memoria. Preferisco, stavolta, usare quelle di altri, per dare uno sguardo ad un tema che inizia a diventare centrale in questa discussione: il modo in cui questa memoria sia entrata a far parte del nostro immaginario collettivo, passando attraverso una rappresentazione pop ma, allo stesso tempo, diventando anch'essa una rappresentazione pop.
Le parole a cui vi rimando sono quelle di Damiano Garofalo, un ricercatore di storia che è responsabile della videoteca della Fondazione Museo della Shoah di Roma, che riflette sulla forza pop della Shoah in questo articolo:
Molti scrivono oggi sulla Shoah. Leggendo qua e là può venire il dubbio che la memoria che oggi ci si ricorda di praticare non sia un vero atto di rammemoriazione, ma solo una forma di partecipazione - più o meno formale - ad un rito civile.
E' utile? La domanda risuona sin da quando, 14 anni fa, questo giorno fu introdotto per legge nel nostro calendario civile. Quanto accaduto l'altro giorno a Roma (i pacchi con le teste di maiale recapitati alla Sinagoga di Roma, al museo che ospita una mostra sulla Shoah e all'ambasciata israeliana: qui e qui la cronaca, qui un commento di Gad Lerner) dimostra che sì, è utile. Ancora e sempre.
Io, oggi, non aggiungerò le mie parole a quelle di chi, con maggiore competenza di me, parla di Shoah e memoria. Preferisco, stavolta, usare quelle di altri, per dare uno sguardo ad un tema che inizia a diventare centrale in questa discussione: il modo in cui questa memoria sia entrata a far parte del nostro immaginario collettivo, passando attraverso una rappresentazione pop ma, allo stesso tempo, diventando anch'essa una rappresentazione pop.
Le parole a cui vi rimando sono quelle di Damiano Garofalo, un ricercatore di storia che è responsabile della videoteca della Fondazione Museo della Shoah di Roma, che riflette sulla forza pop della Shoah in questo articolo:
LA SHOAH È ANCORA “IL MALE ASSOLUTO”?
di minima&moralia pubblicato domenica, 26 gennaio 2014 · 1 Commento
Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria. Vorremmo approfittare di questa occasione di riflessione per postare una serie di tre, quattro articoli sul temi legati alla Shoah e alla memoria.
di Damiano Garofalo
A poco meno di settant’anni dalla fine della guerra e a quasi dieci dall’istituzione internazionale della Giornata della Memoria, è ancora possibile definire la Shoah – lo sterminio di circa sei milioni di ebrei d’Europa – come il paradigma storico del cosiddetto «male assoluto»?
Adorno, l’indicibile e la cultura pop. Nell’era della post-memoria, tutte le immagini assumono un potere iconico: oltre a essere proiettate nella massmedialità, infatti, esse si pongono in una dimensione dialettica con l’immaginario pubblico del trauma. Il percorso di questo immaginario relativo alla Shoah ha però fatto storicamente i conti con delle resistenze culturali, che ne hanno accompagnato l’intero processo formativo.
E poi ad un sito di critica fumettistica, Lo Spazio Bianco, che ha raccolto le recensioni e le riflessioni che ha fatto negli anni sulle diverse narrazioni grafiche dello sterminio, un utile compendio (al di là delle opinioni sui singoli albi) al discorso introdotto da Garofalo. Li trovate qui.
Buona lettura.
Etichette:
Giorno della memoria
Gli anni spezzati (ovvero, della fiction, della storia e del non capirci niente)
Cinquemilionicentoquarantunomila spettatori.
Uno share del 18,66%.
Numeri importanti per la prima puntata di una fiction in tre parti (e sei puntate) di Rai Uno, Gli anni spezzati, per la regia di Graziano Diana (se vi è piaciuta, la pagina facebook è qui e qui c'è il sito dedicato) che racconta, per usare le parole della presentazione ufficiale,
Solo che a questi numeri corrisponde un lavoro che mi limiterò a definire modesto, sia pure entro i canoni della fiction italiana. E poiché non sarebbe corretto pretendere di valutare ore e ore di fiction da una sola puntata, sono sempre pronto a ricredermi se dovessi riuscire a seguire anche le prossime.
Però non ce la faccio a tenermi dal sottolineare un paio di elementi che sono evidenti sin da ora.
Il primo è un dettaglio, qualcosa che magari sarà sfuggito a molti.
Esterno giorno. Scontri in strada. Studenti e operai si menano con la polizia.
E' uno snodo importante per la storia (e, en passant, per le vicende di quegli anni): sono gli scontri di via Larga a Milano, in cui muore l'agente Annarumma che, nella fiction, porta uno dei protagonisti ad un momentaneo ripensamento sulla sua scelta di vita.
Ma ciò che mi colpisce è sullo sfondo: un uomo regge un cartello con scritto, stampatello, FIOM CISL.
Un'inquadratura, niente di più.
Ma quanta superficialità, quanta approssimazione, quanta poca attenzione in quell'oggetto di scena.
Passiamo alle cose più serie.
Quanto sia difficile per il cinema raccontare il terrorismo ormai ce lo hanno detto in molti, da Christian Uva a Alan O'Leary a Luca Peretti e Vanessa Roghi, per non citare che alcuni autori.
Qualche volta la televisione ha dimostrato di saper fronteggiare con capacità la materia: vi ricordate La meglio gioventù? Ecco, con tutti i limiti che gli si possono riconoscere, in quel racconto il tentativo di inquadrare anni difficili era portato avanti con attenzione, cercando di mostrarne la complessità intrecciando continuamente la grande storia e le piccole storie quotidiane.
In questi anni spezzati, invece, c'è qualcosa che lascia perplessi sin dall'introduzione.
Affidata alla voce narrante di un giovane poliziotto, la serie viene aperta da un monologo che, su un montaggio di immagini di repertorio, dice più o meno:
Poi, scioperi e violenza: gli anni spezzati, gli anni '70.
La serie si concluderà nel 1980, con la sconfitta della lotta dei "35 giorni" alla Fiat. Allora, quindi, è lecito ipotizzare sin da ora che, nelle intenzioni degli autori, finiscano gli anni spezzati e comincino anni nuovi, magari da bere e di nuovo belli e spensierati.
Gli anni '70 come parentesi, dunque?
Di nuovo, è solo un'ipotesi che verrà confermata o smentita dal seguito della visione: ma già il fatto che si sia scelto di privilegiare le storie intime e l'intreccio di genere, senza provare neppure ad approfondire il contesto che ha portato a quegli esiti, la dice lunga.
Le strade della fiction e del racconto storico, così, divergono ancora una volta.
E di anni difficili, spezzati o no, sarà difficile capirci qualcosa guardando questo racconto.
Uno share del 18,66%.
 |
| Il cast della fiction Gli anni spezzati |
I dieci anni che hanno sconvolto l’Italia, raccontati dal punto di vista di chi ha combattuto cercando di salvare la nostra Repubblica
Solo che a questi numeri corrisponde un lavoro che mi limiterò a definire modesto, sia pure entro i canoni della fiction italiana. E poiché non sarebbe corretto pretendere di valutare ore e ore di fiction da una sola puntata, sono sempre pronto a ricredermi se dovessi riuscire a seguire anche le prossime.
Però non ce la faccio a tenermi dal sottolineare un paio di elementi che sono evidenti sin da ora.
Il primo è un dettaglio, qualcosa che magari sarà sfuggito a molti.
Esterno giorno. Scontri in strada. Studenti e operai si menano con la polizia.
E' uno snodo importante per la storia (e, en passant, per le vicende di quegli anni): sono gli scontri di via Larga a Milano, in cui muore l'agente Annarumma che, nella fiction, porta uno dei protagonisti ad un momentaneo ripensamento sulla sua scelta di vita.
Ma ciò che mi colpisce è sullo sfondo: un uomo regge un cartello con scritto, stampatello, FIOM CISL.
Un'inquadratura, niente di più.
Ma quanta superficialità, quanta approssimazione, quanta poca attenzione in quell'oggetto di scena.
 |
| il frame in questione |
Passiamo alle cose più serie.
Quanto sia difficile per il cinema raccontare il terrorismo ormai ce lo hanno detto in molti, da Christian Uva a Alan O'Leary a Luca Peretti e Vanessa Roghi, per non citare che alcuni autori.
Qualche volta la televisione ha dimostrato di saper fronteggiare con capacità la materia: vi ricordate La meglio gioventù? Ecco, con tutti i limiti che gli si possono riconoscere, in quel racconto il tentativo di inquadrare anni difficili era portato avanti con attenzione, cercando di mostrarne la complessità intrecciando continuamente la grande storia e le piccole storie quotidiane.
In questi anni spezzati, invece, c'è qualcosa che lascia perplessi sin dall'introduzione.
Affidata alla voce narrante di un giovane poliziotto, la serie viene aperta da un monologo che, su un montaggio di immagini di repertorio, dice più o meno:
quando ero giovane l'Italia usciva dalla guerra, c'era passione e c'era felicità, a casa arrivarono la lavatrice e il frigorifero. Erano anni belli. Poi non ci si capì più niente. Arrivò quella cosa che non ho mai capito bene cosa fosse, la congiuntura, e in strada c'erano scioperi e violenza.Prima, dunque, gli anni belli, gli anni '60.
Poi, scioperi e violenza: gli anni spezzati, gli anni '70.
La serie si concluderà nel 1980, con la sconfitta della lotta dei "35 giorni" alla Fiat. Allora, quindi, è lecito ipotizzare sin da ora che, nelle intenzioni degli autori, finiscano gli anni spezzati e comincino anni nuovi, magari da bere e di nuovo belli e spensierati.
Gli anni '70 come parentesi, dunque?
Di nuovo, è solo un'ipotesi che verrà confermata o smentita dal seguito della visione: ma già il fatto che si sia scelto di privilegiare le storie intime e l'intreccio di genere, senza provare neppure ad approfondire il contesto che ha portato a quegli esiti, la dice lunga.
Le strade della fiction e del racconto storico, così, divergono ancora una volta.
E di anni difficili, spezzati o no, sarà difficile capirci qualcosa guardando questo racconto.
Etichette:
commenti,
serie tv,
televisione
Un post lungo un secolo
Certo che come autore di blog non valgo molto: solo oggi riesco a trovare il tempo - e chissà forse, inconsapevolmente, anche la voglia - di aggiornare queste pagine. E il 2014 è iniziato già da una settimana.
Non vi ho salutato nel 2013 con quelle cose che tutti fanno quando finisce un anno: classifiche delle cose migliori e peggiori e altra roba simile.
Non vi ho accolto nel 2014 con un post di benvenuto: manco un'immagine, un pensiero, qualcosa rubata da qualcun altro.
Niente.
E oggi sono qui a chiedermi pubblicamente se valga ancora la pena tenere un blog se poi non riesci ad aggiornarlo.
Forse arriva un momento in cui bisogna lasciarsi alle spalle qualcosa: le motivazioni, i progetti, le idee cambiano; e ciò che funzionava fino a qualche mese fa, ora non funziona più.
Però.
Però, se gli orologi molli di Dalì con cui ho aperto questo post mi hanno sempre suggerito l'idea di un tempo che fugge, si squaglia e svanisce, il titolo del suo quadro è "la persistenza della memoria".
E dunque non lascio stare.
Non ancora.
Ci proverò a portare avanti queste pagine, magari ripensandole un po'.
E, come si faceva quando eravamo piccoli a inizio anno, formulo i miei buoni propositi per i 12 mesi a venire: una piccola idea per proseguire queste pagine. Se riuscirò a portarla a termine, allora il blog vivrà.
Sennò, vorrà dire che ciò che mi spingeva a tenerlo in piedi non c'è più e, senza rammarico, gli diremo tutti insieme addio.
Se ti interessa sapere cosa ho in mente (e ti stai chiedendo se il titolo del post ha un senso, oppure se ho solo scritto le prime parole che mi sono venute in mente) prosegui dopo il salto. Altrimenti ci sentiamo un'altra volta.
Non vi ho salutato nel 2013 con quelle cose che tutti fanno quando finisce un anno: classifiche delle cose migliori e peggiori e altra roba simile.
Non vi ho accolto nel 2014 con un post di benvenuto: manco un'immagine, un pensiero, qualcosa rubata da qualcun altro.
Niente.
E oggi sono qui a chiedermi pubblicamente se valga ancora la pena tenere un blog se poi non riesci ad aggiornarlo.
Forse arriva un momento in cui bisogna lasciarsi alle spalle qualcosa: le motivazioni, i progetti, le idee cambiano; e ciò che funzionava fino a qualche mese fa, ora non funziona più.
Però.
Però, se gli orologi molli di Dalì con cui ho aperto questo post mi hanno sempre suggerito l'idea di un tempo che fugge, si squaglia e svanisce, il titolo del suo quadro è "la persistenza della memoria".
E dunque non lascio stare.
Non ancora.
Ci proverò a portare avanti queste pagine, magari ripensandole un po'.
E, come si faceva quando eravamo piccoli a inizio anno, formulo i miei buoni propositi per i 12 mesi a venire: una piccola idea per proseguire queste pagine. Se riuscirò a portarla a termine, allora il blog vivrà.
Sennò, vorrà dire che ciò che mi spingeva a tenerlo in piedi non c'è più e, senza rammarico, gli diremo tutti insieme addio.
Se ti interessa sapere cosa ho in mente (e ti stai chiedendo se il titolo del post ha un senso, oppure se ho solo scritto le prime parole che mi sono venute in mente) prosegui dopo il salto. Altrimenti ci sentiamo un'altra volta.
Etichette:
vita del blog