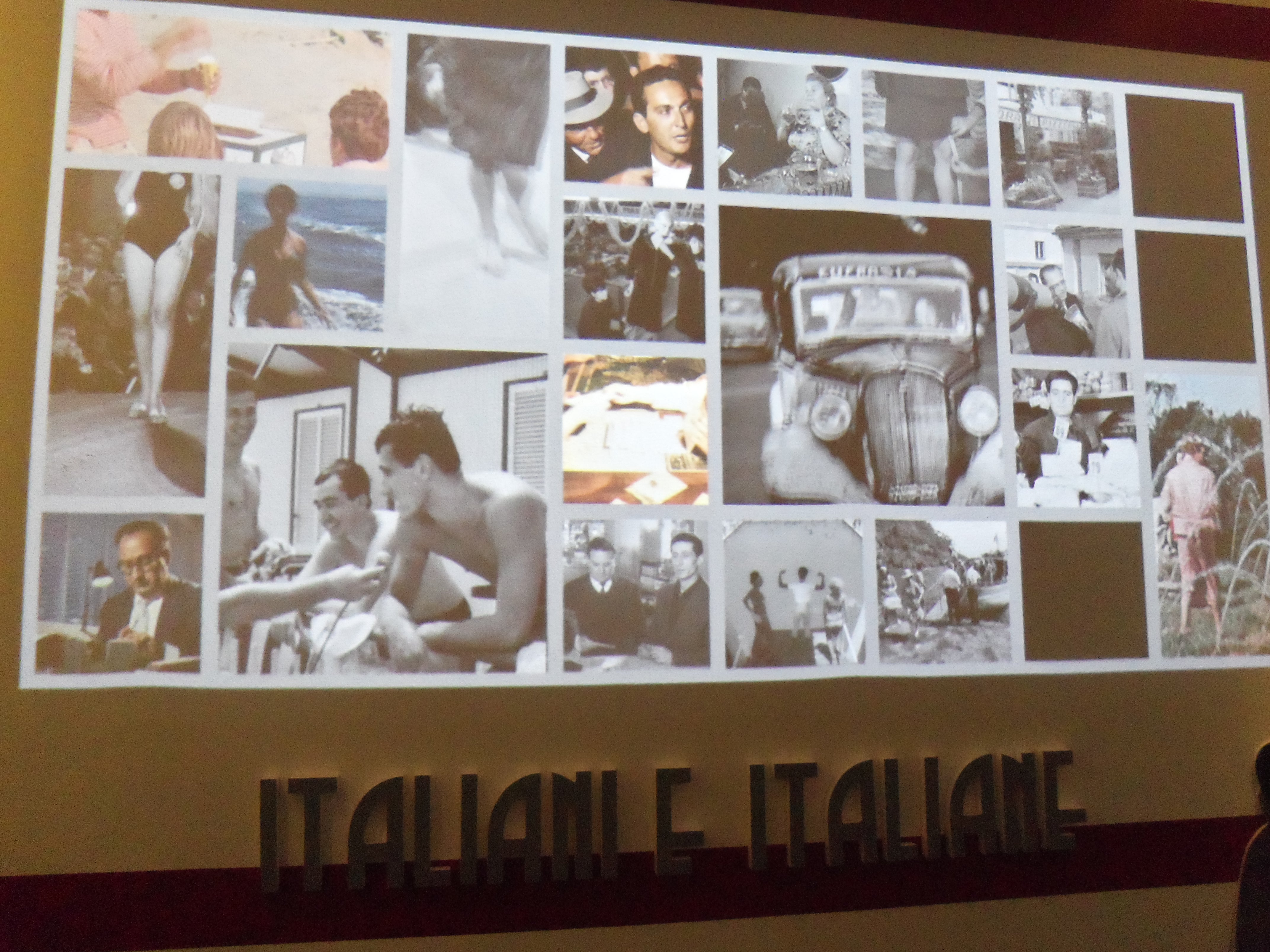Ormai è un anno che il sasso è stato lanciato ma il suo effetto nello stagno dei lettori di fumetti, invece che diminuire col tempo, ha raggiunto le proporzioni di uno tsunami.
 |
Uno splendido ritratto di Dylan Dog,
realizzato da Lorezo Ceccotti (LRNZ)
per la copertina dell'ultimo Dylan Dog Color Fest |
Fuor di metafora (nemmeno tanto riuscita: scusate), è ormai un anno che si aspetta il nuovo corso di Dylan Dog che, voluto dal creatore Tiziano Sclavi, ha investito della responsabilità e dell'onore di rilanciare il personaggio Roberto Recchioni, bravo - in alcune prove anche ottimo - sceneggiatore, disegnatore, profondo conoscitore del medium fumetto e, in generale, dei media, dal cinema al web, che è capace come pochi altri di utilizzare come cassa di risonanza per i propri lavori (prima che lo semi-abbandonasse migrando su facebook, il suo blog
Pronto alla resa era uno dei più seguiti in Italia).
Di recente Recchioni ha rilasciato
un'intervista a Vanity Fair (da lui stesso definita come "la migliore intervista che mi è stata fatta a proposito del nuovo Dylan") in cui, in sostanza, parla della imminente "rivoluzione" su Dylan Dog come di un "ritorno alle origini". Probabilmente è proprio la strada giusta per ridare al personaggio quella forza "rivoluzionaria" che aveva avuto nel 1986, quando era arrivato in edicola, e che poi, col tempo, si era smarrita (per ricomparire a tratti).
Ma dove risiedeva quella
magia che fece di Dyd, oltre che un successo editoriale, un fenomeno di costume? perché chi lo leggeva - e aveva l'età giusta - scopriva di non essere solo, come annota giustamente il Rrobbe nella sua intervista a Vanity Fair? che cosa faceva, cioè, di Dylan Dog un fenomeno identitario, cosa che gli ha permesso di resistere a lunghi periodi di sceneggiature opache, in cui ciò che lo aveva reso speciale si rovesciava in un odioso luogo comune?
Le risposte possibili sono davvero molte, e ogni lettore avrà le sue. Le prime che mi vengono in mente (e non penso di essere particolarmente originale) sono: le sceneggiature perfette e geniali di Sclavi, con i loro giochi di citazioni e rimandi, colte e pop allo stesso tempo.
L'originalità dei disegni: il tratto spigoloso, schieliano direi, di Angelo Stano sul primo numero e le ombre alla Battaglia di Roi sul quarto, per non dirne che due, io non le avevo mai viste nelle mie esperienze di lettore fino ad allora (o meglio: le avevo viste sì, ma sulle
riviste, non sui fumetti della stessa casa editrice di Tex. E sicuramente non su Tex).
L'ironia.
Il fatto che riuscissi a ritrovare la mia sensibilità di diciassettenne (le mie incertezze, i miei sogni, i miei ideali...) nel protagonista, che sicuramente non aveva diciassette anni.
eccetera
eccetera
eccetera
(e ogni lettore può completare la lista con le sue risposte preferite)
Se però cerco di andare oltre i ricordi di lettore, con quella patina di nostalgia che inevitabilmente li colora, credo che ci sia qualcosa di più.
Penso infatti che una delle chiavi del successo di Dylan Dog sia derivato dall'essere stato capace di intercettare lo spirito del tempo - degli anni Ottanta, e poi, almeno in parte, dei Novanta -, non per adeguarvisi ma per criticarlo. E criticarlo, diciamo pure
smontarlo, con le armi della stessa cultura popolare che stava costruendo quell'immaginario.
Per dire: nel 1986, mentre in edicola arriva Dylan Dog, al cinema c'è
9 settimane e mezzo. In quel film, certo, c'è Kim Basinger che si spoglia al ritmo di
You can leave your hat on di Joe Cocker: ed è forse questa la scena che è rimasta piantata nell'immaginario collettivo. Ma c'è anche Mickey Rourke che incarna lo spirito yuppie quando spiega che il suo lavoro è "fare soldi con i soldi". Dylan, invece, di soldi ne chiede pochi - appena "cinquanta sterline al giorno più le spese" - e spesso vi rinuncia pure.
Dite che è solo una coincidenza? Ma è proprio questo che mi sembra interessante: non credo che gli autori abbiano cercato questa
corrispondenza inversa ed è dunque proprio la sua casualità a renderla significativa di qualcosa di più profondo. Credo allora che se andassimo a guardare con attenzione le storie, cercando i possibili punti di contatto con l'immaginario collettivo che si andava allora formando, ne troveremmo diverse altre. E' un lavoro un po' lungo da fare: quasi un buono spunto per un saggio (se mai ci fosse qualcuno disposto a pubblicarlo...) ma sicuramente troppo per un post.
Però, seguendo questa linea di riflessione, mi sembra chiaro che l'
ethos individualista degli anni '80 (per dirla con le parole di
Marco Gervasoni) e quello di Dylan Dog sono in perfetta contrapposizione: empatia e attenzione nei confronti dell'altro caratterizzano l'atteggiamento morale e il comportamento dell'indagatore dell'incubo, laddove i modelli di comportamento diffusi sembrano invece indulgere ad un atteggiamento (appunto) individualista, concentrato su se stessi e sulla propria possibilità di raggiungere gli obiettivi che ci si è dati, anche a scapito degli altri (erano gli anni in cui si diffondeva l'idea che, come diceva Margaret Thatcher, "la società non esiste, esistono solo gli individui...").
In realtà, questo scontro fra diversi
ethos è addirittura più profondo. Uno dei concetti portanti della "filosofia" di Dylan Dog
(se siete fra coloro che credono che il fumetto sia roba da bambini e che non sia possibile parlarne, ricredetevi: per esempio qui e qui), è che "i mostri siamo noi", massima che a me sembra essere un rovesciamento dell'ethos individualistico in una profonda assunzione di responsabilità, piena di senso civico (vi dice niente Johnny Freak?).
Oppure, ancora, prendete una delle caratteristiche di Dylan, il suo romanticismo: non è in perfetta contrapposizione con il cinismo che sembra diventare così diffuso in quegli anni?
E allora, tornando all'inizio di questo post, il ritorno alle origini può senz'altro essere una buona strada per un rinnovamento profondo della serie senza che questo significhi stravolgerne la filosofia. A me sembra che alcune delle storie di Roberto Recchioni (o di Paola Barbato, per citare un'altra eccellente sceneggiatrice della serie) si siano mosse in quella direzione: penso ad esempio a
Mather Morbi e a
Il giudizio del corvo, entrambe vicende che cercano di mettere a nudo il nocciolo pulsante dell'umanità di Dylan scarnificandone il personaggio.
Rimane un punto interrogativo: Recchioni si è formato
con quella e
di quella cultura, come appare chiaro in molti suoi lavori, ispirati (oltre che a molte altre cose) all'immaginario degli anni '80 e, soprattutto, '90. Potrebbe quindi venire meno quella distanza critica che - immagino - nutrisse Sclavi quando scriveva alcune storie dylaniate. Ma Recchioni è troppo intelligente per cadere in questa trappola e non aderire al "canone" Dylan Dog, snaturandone una delle intime nature.
Forse, invece, ciò che bisognerà fare (e che mi sembra, dalle anticipazioni che sono state fatte trapelare, abbiano in animo di fare) sarà aggiornare ai nostri tempi quella che ho chiamato una
corrispondenza inversa: per rinnovarsi Dylan dovrà tornare ad essere in sintonia con i suoi tempi (che sono quelli dei lettori di oggi, e non quelli in cui è nato), estrarne il nucleo profondo e mostrarlo a tutti, grondante contraddizioni e orrori, insieme al proprio cuore, pulsante e sanguinante.
Insomma, levarsi la maschera, ormai un po' screpolata, dell'indagatore dell'incubo e tornare ad essere Dylan.